Cos'è la Spondilite Anchilosante?
- Alessandro Senatore
- 1 giu 2025
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 18 giu 2025
La Spondilite Anchilosante e le Spondiloartriti
La Spondilite Anchilosante (SA) è una malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente le articolazioni sacro-iliache e la colonna vertebrale, ma che può coinvolgere anche le articolazioni periferiche.
La SA, come l’artrite reattiva, l’artrite psoriasica, le artriti associate a malattie infiammatorie intestinali (morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa) e le spondiloartriti indifferenziate, fa parte del gruppo delle spondiloartropatie (SpA).
Nel gruppo delle malattie reumatiche infiammatorie, la SA è la diagnosi più comune dopo l’artrite reumatoide; ha un'incidenza 3 volte maggiore nel sesso maschile, esordisce in genere in pazienti di età compresa tra i 20 e i 40 anni ed è 10-20 volte più frequente in parenti di primo grado di pazienti con SA, rispetto alla popolazione generale.
Non si conoscono ancora le cause della SA. La presenza dell’aplotipo HLA B27 (è un gene, quindi ereditato da uno o entrambi i genitori) è strettamente associato alla malattia.L’HLA-B27 da solo non causa la malattia e solamente il 5% delle persone che hanno l’ HLA B27 sviluppano dei sintomi. Ma la SA non è una malattia ereditaria. I nati da soggetti con SA hanno solamente un rischio aumentato di ammalarsi di questa malattia reumatica (come ad esempio è dimostrato nel diabete o nella ipertensione).
Come si manifesta?
Il sintomo d'esordio più frequente è il dolore al rachide lombare (lombalgia), con le caratteristiche del dolore infiammatorio: prevalentemente notturno, peggiora con il riposo e migliora con il movimento, si associa a rigidità mattutina. Il miglioramento del dolore con il movimento è un elemento distintivo rispetto alle forme degenerative del rachide (artrosi) e alle discopatie, dove viceversa il movimento e lo sforzo rappresentare elementi scatenanti o peggiorativi del dolore.
Nel lungo termine l’infiammazione della colonna vertebrale può determinare la completa fusione della colonna stessa (colonna a canna di bamboo) determinando nel paziente un profondo grado di disabilità.
Il paziente si incurva, perde le regolari curvature della colonna, ha difficoltà o non riesce a stare eretto, non riesce a flettersi, non è in grado di piegarsi a raccogliere un oggetto, non riesce (se non con l’aiuto di ausili) a raggiungere od afferrare un oggetto posto in alto sopra la testa, non è in grado di alzarsi dalla sedia senza aiutarsi con le braccia o senza l’ausilio di un’altra persona, non è in grado di stare in piedi senza aiuto, non è in grado di salire 12-15 gradini senza corrimano o bastone, non è in grado di guardarsi alle spalle, di girare il collo senza girare l’intero corpo, non è in grado di effettuare esercizi fisici e di svolgere le comuni attività della vita quotidiana ed il proprio lavoro. Chiaramente queste limitazioni possono essere più o meno gravi a seconda della gravità di malattia.Il principale bersaglio anatomico della infiammazione nella spondilite anchilosante è l’entesi. L’infiammazione delle entesi e la loro trasformazione progressiva in tessuto osseo spiegano gran parte dei sintomi presenti nella SA.
In alcuni pazienti sono riscontrabili anche manifestazioni extra-articolari come quelle oculari caratterizzate da episodi ricorrenti di arrossamento, dolore e ipersensibilità alla luce (uveite anteriore). L’infiammazione dell’occhio richiede un precoce riconoscimento e un adeguato trattamento da parte di un oculista per prevenire il danno oculare.
Altre manifestazioni extra-articolari (non frequenti) sono l’impegno cardiaco, l’impegno polmonare, l’impegno neurologico e quello renale.
Tali manifestazioni insorgono in genere in pazienti con lunga storia di malattia, specie se non trattata adeguatamente.
Da segnalare inoltre tra le complicanze è l'osteoporosi, malattia che predispone ad un maggior rischio fratturativo.
Come si fa la diagnosi?
La diagnosi di SA dipende da una attenta storia clinica e dall’esame fisico. Due elementi della storia clinica sono di grande importanza:
la presenza di dolore con le caratteristiche della forma infiammatoria e la rigidità della parte inferiore della schiena
una storia familiare positiva per SA.
Il dolore della parte inferiore della schiena è molto comune nella popolazione generale ed è solitamente dovuto a cause “meccaniche” non infiammatorie come l’artrosi o l’ernia discale. Il dolore alla schiena della SA ha le caratteristiche della forma infiammatoria.
La presenza di una lombalgia infiammatoria è l’elemento chiave per la diagnosi di SA.
Una diagnosi certa (definita) di SA richiede la presenza di evidenza radiologica ad una lastra del bacino, di infiammazione delle articolazioni sacroiliache (sacroileite). Tali alterazioni radiologiche compaiono però dopo 3-5 anni di malattia; non sono quindi utili ad una diagnosi precoce di SA.
Anche se la diagnosi di SA non richiede solitamente la determinazione dell’HLA-B 27, tale test può essere utile a fini diagnostici.
Gli altri esami del sangue non sono utili per la diagnosi di SA. In particolare possono essere normali i comuni esami che indicano infiammazione (VES e PCR).
Quale la prognosi?
Il decorso della malattia è molto variabile spesso caratterizzato da fasi di acuzie alternate a fasi di remissione. La malattia può avere un decorso favorevole, relativamente mite e non progressivo. In alcuni casi peraltro la malattia può essere persistentemente attiva con progressivo danno e progressivo deficit di funzione. Il tempo tra l’esordio dei sintomi e la diagnosi è ancora purtroppo di anni e questo non facilità un approccio corretto alla malattia. La limitazione della funzione legata alla ossificazione progressiva della colonna e-o ad un impegno articolare periferico, specie delle grosse articolazioni come le anche, aumenta con la durata di malattia e può compromettere anche severamente la capacità della cura di sé, di lavoro e dello svago. Una costante e specifica chinesiterapia ed una terapia occupazionale e medica adeguate ritardano la progressione. Possono essere condizioni favorenti l’aggravamento funzionale un lavoro che obblighi ad eccessivo stazionamento in piedi ed anche una frequente e prolungata esposizione al freddo.
Da segnalare che gli anni che incidono sulla prognosi sono i primi anni di malattia. Paiono particolarmente importanti i primi 10 anni di malattia. Un controllo della attività di malattia con le terapie a disposizione nei primi anni appare quindi fondamentale. Da qui la importanza di un accorciamento dei tempi di diagnosi ancora, come già detto, troppo lunghi.
Quale la terapia?
La fisioterapia, le corrette abitudini posturali, i farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) sono alla base del trattamento del dolore e della rigidità causate dalla SA. FANS comunemente utilizzati sono l’indometacina, il diclofenac, il naproxene, il piroxicam e i più recentemente introdotti inibitori specifici della Cox-2 come il celecoxib e l’etoricoxib. La chinesiterapia è la base della terapia: deve essere specifica, costante e regolare. I FANS riducono il dolore, migliorano l’infiammazione e vengono considerati, in questa malattia, “curativi”. Il loro uso, per gli effetti dannosi specie gastro-entrici, va peraltro monitorato.
I corticosteroidi ed i farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARDs), quali la sulfasalazina, il methotrexate sono attivi nel controllare i sintomi articolari periferici ma non nei sintomi a carico della colonna vertebrale. Inoltre tali farmaci non hanno la capacità di rallentare l’evoluzione del danno alla colonna vertebrale.La terapia della SA si è recentemente arricchita di nuovi farmaci in grado di bloccare una sostanza chiamata Tumor Necrosis Factor alfa (TNF alfa) responsabile del mantenimento della infiammazione nella SA. Tali farmaci sono in grado di sopprimere l’infiammazione e quindi risolvere il dolore e probabilmente prevenire l’evoluzione del danno articolare (anchilosi della colonna vertebrale). La prima di queste molecole, sintetizzate mediante tecniche di biotecnologia genetica, è stata l’infliximab, un anticorpo monoclonale chimerico (uomo/topo) che lega selettivamente il TNF-alfa solubile rendendolo inattivo. Vi sono evidenze che l’impiego di infliximab nelle fasi iniziali del processo spondilitico, può determinare una reversione dell’edema osseo (segno di infiammazione) evidenziato in risonanza magnetica a carico delle articolazioni sacroiliache e della colonna vertebrale a testimonianza di una regressione del danno flogistico. Oltre a infliximab sono oggi disponibili altri farmaci biologici anti TNFalfa: etanercept che è il recettore antagonista del TNFalfa e adalimumab, altro anticorpo monoclonale. Più recentemente si sono affiancati ai farmaci biologici anti-TNF con efficacia paragonabile, nuovi farmaci biologici ad azione anti-IL17 (Secukinumab) ed anti-IL12/23 (Ustekinumab) molecole coinvolte nella patogenesi di questa malattia. Di più recente impiego con risultati incoraggianti nel trattamento della SA sono gli JAK inibiori: piccole molecole che agiscono bloccando a livello intracellulare la cascata infiammatoria propria di questa patologia.
Queste molecole rappresentano una reale terapia per la spondilite.
Un trattamento che in alcuni casi viene effettuato nei pazienti con spondilite che hanno infiammazione (edema) dell’osso è quello con pamidronato o con altri bisfosfonati che sono farmaci che si usano nella terapia della osteoporosi e che riducono il riassorbimento osseo. Il trattamento con tali farmaci viene fatto per infusione endovena per alcuni mesi di terapia.
Quali pazienti possono essere trattati con biologici?
Attualmente la terapia con i farmaci biologici è riservata ai pazienti con diagnosi certa (secondo i criteri di New York 1984), che presentano una malattia attiva per almeno 4 settimane, con scale (criteri di valutazione di attività) specifiche di attività di malattia alterate ed opinione di un esperto; è richiesto inoltre il fallimento terapeutico della terapia convenzionale. Il fallimento è definito dalla persistenza di malattia attiva nonostante un trattamento adeguato con almeno 2 FANS per almeno 3 mesi ciascuno a dose piena, se tollerato, in caso di sola spondilite; se paziente con artrite periferica, deve esserci resistenza alla terapia con steroide intra-articolare (almeno due infiltrazioni) ed alla salazopirina a dose piena (2-3 grammi al giorno) per 4 mesi; se paziente con entesite deve esserci non risposta ad almeno 2 infiltrazioni. La valutazione della malattia viene fatta attraverso una serie di parametri (ASAS score set) che prevedono delle scale di valutazione della funzione (BASFI), la valutazione del dolore rachideo nell'ultima settimana, della motilità del rachide (espansione toracica, Schober test, distanza occipite muro, flessione lombare latrale, rotazione cervicale, distanza intramalleolare), la valutazione globale di malattia da parte del paziente, la presenza e la durata della rigidità mattutina nell’ultima settimana, il numero di articolazioni rigonfie (su 44), lo score entesi (valutazione di impegno delle entesi), la VES, PCR ed il grado di faticabilità.
Rappresentano controindicazioni al loro uso la gravidanza, l’allattamento, una infezione attiva, un alto rischio di infezioni (storia di TBC, ulcere cutanee croniche, artrite settica entro 12 mesi, infezione protesica, ricorrenti infezioni polmonari, catetere vescicole a dimora), una storia di connettiviti (LES), di malattie neurologiche demielinizzanti (sclerosi multipla), di neoplasie (escluso basalioma) trattate con successo nei 10 anni prima. La terapia va poi monitorata regolarmente, va valutata la sua efficacia (entro 12 settimane) e la persistenza della efficacia. Certamente questi farmaci sono molto importanti per tale malattia, paiono rappresentare la prima reale terapia, ma vanno controllati adeguatamente.
Dottore Valerio Pittoni



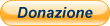
Commenti